Articolo in due parti.
 Matthew Phipps Shiell (dopo il suo arrivo a Londra si deciderà per l’ablazione della seconda “l” per motivi “di penna”) occupa un posto di tutto rispetto sia all’interno del genere gotico, sia in quanto “padre” della Science fiction “apocalittica” o post-catastrofista. Quando nel lontano 1967 Rodolfo Wilcock scrisse la sua presentazione a “The Purple Cloud”, lo fece in termini entusiastici, in piena linea con le sue premesse “scapigliate”: “Che La nube purpurea, pubblicata nel 1901, sia un capolavoro, continuamente più riuscito e trascendente di un qualsiasi romanzo di Emile Zola – per nominare a caso un grande famoso sull’orlo del secolo – sembra non solo accertabile in sede di lettura, ma anche dimostrabile in sede critica […]”.
Matthew Phipps Shiell (dopo il suo arrivo a Londra si deciderà per l’ablazione della seconda “l” per motivi “di penna”) occupa un posto di tutto rispetto sia all’interno del genere gotico, sia in quanto “padre” della Science fiction “apocalittica” o post-catastrofista. Quando nel lontano 1967 Rodolfo Wilcock scrisse la sua presentazione a “The Purple Cloud”, lo fece in termini entusiastici, in piena linea con le sue premesse “scapigliate”: “Che La nube purpurea, pubblicata nel 1901, sia un capolavoro, continuamente più riuscito e trascendente di un qualsiasi romanzo di Emile Zola – per nominare a caso un grande famoso sull’orlo del secolo – sembra non solo accertabile in sede di lettura, ma anche dimostrabile in sede critica […]”.
Di fronte a tale affermazione non possiamo che dirci d’accordo, ma prima di passare a una disamina più approfondita del “fenomeno nube-purpurea” sarà bene fare luce su certi aspetti poco esplorati dello Shiel scrittore (in casi come il suo la differenza fra arte e vita diventa molto labile, per non dire quasi indistinguibile).
Matthew Phipps Shiel nasce nell’isola indiana di Montserrat, colonia dell’Impero britannico la cui economia si basava, all’epoca, sull’importazione di manodopera schiavistica da impiegare in piantagioni di canna da zucchero gestite in larga parte da emigranti (spesso forzati) di origine irlandese. Il futuro scrittore fu appunto figlio di madre indiana e di padre irlandese, proprietario navale nonché pastore metodista. Dopo il periodo di istruzione primaria e secondaria trascorso alle Barbados, il giovane Shiel si sente pronto per l’approdo a Londra, dove tenterà la sua carriera letteraria.
Con una immaginazione che tutti i suoi critici sono concordi nel definire “debordante” e gusti di impronta sibaritica già praticamente “in toto” sviluppati, il Nostro si appresta con entusiasmo a occupare il suo posto all’interno di quell’ambiente dandy e decadente che la temperie culturale degli inizi del novecento imponeva. Praticamente contemporaneo di Oscar Wilde, possedeva il suo stesso gusto per la stravaganza e per l’eccesso, elementi che non risparmia sia all’interno dei suoi racconti sul Principe Zaleski (meritevoli di aver dato al genere poliziesco una nuova, poderosa spinta in avanti), sia all’interno della sua narrativa palesemente “gotica”.
 Nonostante lo “high cost of living” londinese l’obblighi a esercitare il ruolo di insegnante di grammatica per ragazzi, egli riesce a inserirsi in qualità di traduttore per il noto mensile The Strand dove traduce, fra gli altri, i Contes cruels di Villiers de l’Isle-Adam, operazione che lo mette a contatto sia con il decadentismo “continentale” sia con quello che sarà uno dei suoi più importanti mentori stilistici, Edgar Allan Poe, di cui lo stesso de l’Isle-Adam era appassionato ammiratore.
Nonostante lo “high cost of living” londinese l’obblighi a esercitare il ruolo di insegnante di grammatica per ragazzi, egli riesce a inserirsi in qualità di traduttore per il noto mensile The Strand dove traduce, fra gli altri, i Contes cruels di Villiers de l’Isle-Adam, operazione che lo mette a contatto sia con il decadentismo “continentale” sia con quello che sarà uno dei suoi più importanti mentori stilistici, Edgar Allan Poe, di cui lo stesso de l’Isle-Adam era appassionato ammiratore.
Nel 1896, Shiel pubblica per John Lane un volumetto contenente le storie del Principe Zaleski, con un frontespizio illustrato da Aubrey Beardsley per la prestigiosa serie “Keynotes”. La conoscenza di Lane, editore in contatto con le personalità artistiche più di spicco nella Londra di inizio secolo, è importante per Shiel che acquista familiarità con scrittori quali Richard Le Gallienne, Lionel Johnson e un giovane Arthur Machen, anche lui di fresco approdo a Londra.
Approssimativamente in questo periodo possiamo far risalire l’adesione di Shiel alla Golden Dawn, forse per tramite dello stesso Machen, di cui il Nostro resterà amico fraterno. Se Blackwood e Machen videro nella Golden Dawn un’occasione per sviluppare il loro proprio personale percorso mistico, Shiel vi trovò immediatamente lo specchio della sua propria concezione della magia come “anti-scienza” in senso provocatorio, anti-progressista e soprattutto anti-britannico, rimanendo probabilmente impressionato dalla sontuosità e dal barocchismo dei rituali di magia cerimoniale esibiti da S.L. MacGregor Mathers.
In questo si rivelò adepto speculare al francese Joséphin Péladan, che iniziato anch’esso alla Massoneria dal più sobrio Stanislas de Guaita, ne adotterà in pieno l’aspetto più ritualmente appariscente, fondando un “salotto esoterico” e facendosi chiamare “Sar” (“principe” in lingua persiana) Péladan. La magia per Shiel si presenta come l’aspetto più oscuro e “lunare” del Mondo, legata ai misteri del sesso e alla dicotomia tanto in auge durante il decadentismo, di “Eros kai Thanatos”, avvicinandosi in questo a quell’altro decadentista impenitente che fu il giovane Aleister Crowley.
 La sua raccolta di racconti gotici più conosciuta, Shapes in the Fire (ristampata come Xelucha and Others dall’editrice statunitense Arkham House, con l’inserimento aggiuntivo di alcuni racconti tratti da altre antologie) costituisce, fondamentalmente, una riproposizione di temi tipici della narrativa di Edgar Allan Poe arricchiti da spunti esoterici, commistione che rivela un’indubbia originalità di fondo.
La sua raccolta di racconti gotici più conosciuta, Shapes in the Fire (ristampata come Xelucha and Others dall’editrice statunitense Arkham House, con l’inserimento aggiuntivo di alcuni racconti tratti da altre antologie) costituisce, fondamentalmente, una riproposizione di temi tipici della narrativa di Edgar Allan Poe arricchiti da spunti esoterici, commistione che rivela un’indubbia originalità di fondo.
“Xelucha” è un racconto tutto incentrato sulla figura dell’“Eterno Femminino” inteso in chiave ambigua e mortifera in puro stile decadentista, e si può leggere come una variazione sul tema delle “morte affascinanti” di Poe; Eleonora, Ligeia e Morella, ma con in più una forte componente “messianica” che non trova eguali nella tematica decadentista del tempo, ma che troverà uno stuolo di imitatori in quella successiva.
Xelucha è una donna “totale”, una manifestazione del Divino inteso nella sua veste più feroce e “dionisiaca”. La sua presenza trasforma le strade della filistea Londra (tema preferito di Shiel, che successivamente la chiamerà direttamente “città di birrai”) in un “baccanale di luci”. Le metafore si susseguono vertiginosamente: Xelucha viene paragonata a una stella (quella di Betlemme? Siamo di fronte a una Natività in chiave femminile?), una iniziatrice di misteri, una sacerdotessa, addirittura una Dea. Assume anche tratti vampirici che la avvicinano alla Helen Vaughan del macheniano “The Great God Pan”, dal momento che anima di una vita oscura e parassitaria un amico del narratore ridotto, dopo la partenza di Xelucha “in Oriente”, a nient’altro che “una larva priva di vita”.
Xelucha decide di partire, appunto, “per dominare l’Oriente” (ossessione onnipresente di Shiel che mai mancherà di rimarcare la sua estraneità al tipo dell’inglese medio, ribadendo fino alla nausea le sue origini indiane), ma laggiù è preda di una malattia che la consuma, anche se “voci” dicono “che Ella non è morta”. Oppresso da una debolezza tutta dandy, una sera il narratore si ritrova a meditare stancamente su di una terrazza e viene avvicinato da una donna di bassa statura, di grande bellezza e fascino. Shiel insiste sul suo seno prosperoso non solo mosso da una spiccata sensualità, che pure egli propugnava candidamente, quanto per ricalcare la mano sugli attributi numinosi della prosperità che è propria delle Dee antiche.
La donna riconosce in lui “un Compagno” e lo guida con sé attraverso una Londra oscura e diafana. I due giungono infine in una casa “arredata secondo il gusto orientale più sfrenato”, vi si avvicendano lampade di diaspro e incensieri accesi, tovaglie di velluto e treppiedi; vi fa da contrasto solo una semplice bottiglia contenente “vino nero”, forse il “Vinum Sabbati” della conoscenza dionisiaca che riduce uno dei protagonisti di Machen a un’orribile larva pre-adamitica. Colà, la strana donna intavola una discussione con il protagonista, mettendone alla berlina le convinzioni borghesi, il “senso comune” anti-iniziatico del quale Shiel si professerà sempre nemico con attitudini gigionesche tipiche della temperie culturale della quale si sentiva figlio, ed erede a tutti gli effetti.
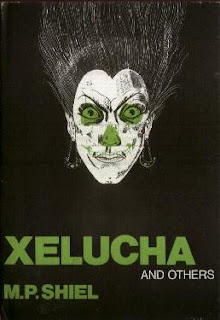 La donna parla del culto del fuoco dei sabei (una popolazione minoritaria dell’Iraq del nord, considerata discendente degli antichi babilonesi e tutt’ora esistente), il fuoco della “Ekpyrosis”, la grande conflagrazione apocalittica professata dagli stoici nel tardo impero romano, influenzati da dottrine orientali. Il senso comune che la donna mette alla berlina è la cecità di un mondo debole, incapace di abbracciare la morte, la larva in decomposizione che cela in sé la fiamma dell’Apocatastasi finale, l’incendio dell’Universo che “immetterà vino nuovo in botti vecchie”. I suoi discorsi insistono su immagini macabre: un consesso di morti in una tomba norvegese, le teste delle mummie poggiate sulle ginocchia consumate, il suono dei denti che attraversano la carne ammuffita per ticchettare sui pavimenti di pietra come perle cadute.
La donna parla del culto del fuoco dei sabei (una popolazione minoritaria dell’Iraq del nord, considerata discendente degli antichi babilonesi e tutt’ora esistente), il fuoco della “Ekpyrosis”, la grande conflagrazione apocalittica professata dagli stoici nel tardo impero romano, influenzati da dottrine orientali. Il senso comune che la donna mette alla berlina è la cecità di un mondo debole, incapace di abbracciare la morte, la larva in decomposizione che cela in sé la fiamma dell’Apocatastasi finale, l’incendio dell’Universo che “immetterà vino nuovo in botti vecchie”. I suoi discorsi insistono su immagini macabre: un consesso di morti in una tomba norvegese, le teste delle mummie poggiate sulle ginocchia consumate, il suono dei denti che attraversano la carne ammuffita per ticchettare sui pavimenti di pietra come perle cadute.
Il protagonista prova a scacciare tali fantasie macabre dalla testa di quella che crede solo una sua eccentrica, prossima conquista, invitandola a libare con lui all’amore, ma la donna lo schernisce, forse con lo scherno dell’Iniziato superiore che “porta in sé l’ebbrezza” e non ha bisogno, dunque di stimoli interni. Infine, sconfitto, il narratore cede e in un momento di spossatezza crede di riconoscere in lei la scomparsa Xelucha, per esserne di nuovo schernito: “Pazzo, Ella è morta, il colera la prese. Il morbo consumò la carne della sua guancia fino ai denti”. La Donna parla di una vita oltre la morte, parla di una corruzione universale che, una volta giunta al suo parossismo, trasformerà il mondo, ma il protagonista cede e cade svenuto. Al suo risveglio si ritroverà in un sudicio appartamento, vuoto e polveroso. Unico resto della sua folle notte, una bottiglia di vino per metà vuota.
Per tutto il racconto, peraltro breve, si respira un’aria di abbandono e malattia e al tempo stesso, per contrasto, un’atmosfera di vibrante eccitazione suggerita da immagini di potente sensualità. In “Xelucha” si rimane catturati da una terribile ambiguità che nasconde il messianismo nella follia e viceversa. Come non pensare dunque al “Riparatore di reputazioni” di R. W. Chambers di cui questo racconto è chiaramente ispiratore? In Chambers viene rappresentata la stessa aria messianica, c’è tutta la follia del fanatismo apocalittico incarnata nella figura dell’“Imperatore d’America”. In “The Yellow Sign”, inoltre, rimane immutata tutta l’insistenza su fantasie di morte di “Xelucha” (Il custode del cimitero “che somiglia a un grasso verme”, etc.) mentre l’attesa di una Rivelazione apocalittica rimane sempre in agguato, stavolta sotto forma di un terribile libro.
Insomma, non ci vuole una grande immaginazione per riconoscere che fra le scollature ubertose di Xelucha fanno già capolino gli stracci polverosi de “Il Re in Giallo”, anche loro annunciatori di una prossima Apocalisse. H.P. Lovecraft parlerà più in là di un “Mago”, Nyarlatothep, anch’egli proveniente dall’Oriente, anch’egli un facitore di miracoli (la morte verrà con lui), mentre Clark Ashton Smith rappresenterà tutta una serie di terribili incantatrici e vampire da “Morthylla” a “L’Incantatrice di Sylaire”, tutte caratterizzate da una carnagione “vicina al pallore della morte” (Xelucha è prosperosa ma “circonfusa da una luce bianca e diafana”) e manifestantesi tutte in prossimità di una catastrofe imminente.
 In pratica, questo racconto di Shiel è la dimostrazione più lampante del fatto che considerare la sua produzione “gotica” come meramente tributaria di Poe, operazione che David Punter implicitamente suggerisce, è ipotesi riduttiva e quanto meno azzardata. In Edgar Allan Poe, “abbracciare la morte” non supera il livello della fantasia macabra (sicuramente suggerita dalla morte prematura della sua adorata Virginia), mentre in Shiel assume proporzioni cosmiche, un buon preludio ai fasti de La nube purpurea.
In pratica, questo racconto di Shiel è la dimostrazione più lampante del fatto che considerare la sua produzione “gotica” come meramente tributaria di Poe, operazione che David Punter implicitamente suggerisce, è ipotesi riduttiva e quanto meno azzardata. In Edgar Allan Poe, “abbracciare la morte” non supera il livello della fantasia macabra (sicuramente suggerita dalla morte prematura della sua adorata Virginia), mentre in Shiel assume proporzioni cosmiche, un buon preludio ai fasti de La nube purpurea.
“The House of Sounds” (osannato da Lovecraft) è una originale variazione su “La caduta della casa degli Usher” di Poe. Qui, la prima cosa che si nota è una sorta di cameratismo che intercorre fra i due protagonisti, elemento che in Poe sussiste solo in potenza mentre il resto della narrazione è un vero e proprio prodigio stilistico. Il rumore onnipresente della cateratta è un geniale escamotage di Shiel, in un ambiente dove l’udito è cancellato la comunicazione si fa impossibile; dovrà dunque per forza essere di tipo visivo, e qui la prosa di Shiel, che definire “scoppiettante” è dire poco, è al suo meglio.
La casa è letteralmente “assediata” dal ruggito della cateratta, simbolo della Realtà, giornalmente erosa dall’attacco della follia come la mente dei protagonisti. Per reazione, la casa squaderna la propria risposta spaziale a ciò che spazio non possiede, né dimensioni: il suono. I piani si avvicendano ai piani, le stanze alle stanze, le superfici di vetro alle superfici, nel patetico tentativo di riflettere qualcosa di diverso dalla propria bruciante ossessione. La reiterazione delle parole “rumore” e “frastuono” è talmente ossessiva che il lettore non potrà evitare di cominciare a sentire la lontana eco di un boato… e l’invitabile finale non si farà attendere.
In “L’oscuro destino di un certo Saul” Shiel si cimenta invece con “l’assenza” di luce, non perdendo ugualmente nulla in vivacità. Un naufrago viene gettato in mare, chiuso in una botte, per approdare in una caverna sottomarina dove regnano le tenebre, variazione stavolta sul Gordon Pym dello scrittore di Boston. All’inizio il naufrago lamenta la sua condizione meschina, ma un pensiero religioso illumina il racconto di una luce oscura: “Se salgo sù, in Paradiso, Lui (leggi: Dio) è lì; se faccio il mio letto nell’Inferno, Lui è là; se prendo il volo di mattina e mi fermo nella zona più lontana dell’Oceano anche lì troverò la Sua mano che guiderà il mio cammino. Anche lì la Sua mano destra mi sosterrà”.
Questo diventa la stura ironica e crudele di Shiel per “mettere alla prova” il suo protagonista. Il signor Saul trova la maniera di fare luce usando dei papiri, ma il suo è un mondo immerso nelle tenebre, laghi sotterranei enormi si spalancano nell’abisso, isole solitarie e tunnel. L’ironia antisociale di Shiel si scatena anche qui: il protagonista trova delle radici di mescalina e comincia ad assumerle quotidianamente (la droga, come pure il sesso, sono elementi chiave nella narrativa di Shiel). L’uso della pianta psicotropa, unita alla percezione costante di un mondo oscuro, apre nella mente del protagonista una “visione notturna” da intendersi forse in senso iniziatico, contrapposta a quella “diurna” della sua vita passata in superficie. Il suo Dio diviene un Dio sotterraneo e Ctonio, il suo avatar, una Creatura Mostruosa che vive nelle acque, dalla forma vagamente antropomorfa, gli occhi ciechi, la bocca aperta in un urlo immane e silenzioso (forse un antenato del “Dagon” di Lovecraft?), visione inquietante e spaventosa forse indotta dall’uso della droga e dalle riflessioni religiose del signor Saul. O forse no?
[Continua]
 Matthew Phipps Shiell (dopo il suo arrivo a Londra si deciderà per l’ablazione della seconda “l” per motivi “di penna”) occupa un posto di tutto rispetto sia all’interno del genere gotico, sia in quanto “padre” della Science fiction “apocalittica” o post-catastrofista. Quando nel lontano 1967 Rodolfo Wilcock scrisse la sua presentazione a “The Purple Cloud”, lo fece in termini entusiastici, in piena linea con le sue premesse “scapigliate”: “Che La nube purpurea, pubblicata nel 1901, sia un capolavoro, continuamente più riuscito e trascendente di un qualsiasi romanzo di Emile Zola – per nominare a caso un grande famoso sull’orlo del secolo – sembra non solo accertabile in sede di lettura, ma anche dimostrabile in sede critica […]”.
Matthew Phipps Shiell (dopo il suo arrivo a Londra si deciderà per l’ablazione della seconda “l” per motivi “di penna”) occupa un posto di tutto rispetto sia all’interno del genere gotico, sia in quanto “padre” della Science fiction “apocalittica” o post-catastrofista. Quando nel lontano 1967 Rodolfo Wilcock scrisse la sua presentazione a “The Purple Cloud”, lo fece in termini entusiastici, in piena linea con le sue premesse “scapigliate”: “Che La nube purpurea, pubblicata nel 1901, sia un capolavoro, continuamente più riuscito e trascendente di un qualsiasi romanzo di Emile Zola – per nominare a caso un grande famoso sull’orlo del secolo – sembra non solo accertabile in sede di lettura, ma anche dimostrabile in sede critica […]”.Di fronte a tale affermazione non possiamo che dirci d’accordo, ma prima di passare a una disamina più approfondita del “fenomeno nube-purpurea” sarà bene fare luce su certi aspetti poco esplorati dello Shiel scrittore (in casi come il suo la differenza fra arte e vita diventa molto labile, per non dire quasi indistinguibile).
Matthew Phipps Shiel nasce nell’isola indiana di Montserrat, colonia dell’Impero britannico la cui economia si basava, all’epoca, sull’importazione di manodopera schiavistica da impiegare in piantagioni di canna da zucchero gestite in larga parte da emigranti (spesso forzati) di origine irlandese. Il futuro scrittore fu appunto figlio di madre indiana e di padre irlandese, proprietario navale nonché pastore metodista. Dopo il periodo di istruzione primaria e secondaria trascorso alle Barbados, il giovane Shiel si sente pronto per l’approdo a Londra, dove tenterà la sua carriera letteraria.
Con una immaginazione che tutti i suoi critici sono concordi nel definire “debordante” e gusti di impronta sibaritica già praticamente “in toto” sviluppati, il Nostro si appresta con entusiasmo a occupare il suo posto all’interno di quell’ambiente dandy e decadente che la temperie culturale degli inizi del novecento imponeva. Praticamente contemporaneo di Oscar Wilde, possedeva il suo stesso gusto per la stravaganza e per l’eccesso, elementi che non risparmia sia all’interno dei suoi racconti sul Principe Zaleski (meritevoli di aver dato al genere poliziesco una nuova, poderosa spinta in avanti), sia all’interno della sua narrativa palesemente “gotica”.
 Nonostante lo “high cost of living” londinese l’obblighi a esercitare il ruolo di insegnante di grammatica per ragazzi, egli riesce a inserirsi in qualità di traduttore per il noto mensile The Strand dove traduce, fra gli altri, i Contes cruels di Villiers de l’Isle-Adam, operazione che lo mette a contatto sia con il decadentismo “continentale” sia con quello che sarà uno dei suoi più importanti mentori stilistici, Edgar Allan Poe, di cui lo stesso de l’Isle-Adam era appassionato ammiratore.
Nonostante lo “high cost of living” londinese l’obblighi a esercitare il ruolo di insegnante di grammatica per ragazzi, egli riesce a inserirsi in qualità di traduttore per il noto mensile The Strand dove traduce, fra gli altri, i Contes cruels di Villiers de l’Isle-Adam, operazione che lo mette a contatto sia con il decadentismo “continentale” sia con quello che sarà uno dei suoi più importanti mentori stilistici, Edgar Allan Poe, di cui lo stesso de l’Isle-Adam era appassionato ammiratore.Nel 1896, Shiel pubblica per John Lane un volumetto contenente le storie del Principe Zaleski, con un frontespizio illustrato da Aubrey Beardsley per la prestigiosa serie “Keynotes”. La conoscenza di Lane, editore in contatto con le personalità artistiche più di spicco nella Londra di inizio secolo, è importante per Shiel che acquista familiarità con scrittori quali Richard Le Gallienne, Lionel Johnson e un giovane Arthur Machen, anche lui di fresco approdo a Londra.
Approssimativamente in questo periodo possiamo far risalire l’adesione di Shiel alla Golden Dawn, forse per tramite dello stesso Machen, di cui il Nostro resterà amico fraterno. Se Blackwood e Machen videro nella Golden Dawn un’occasione per sviluppare il loro proprio personale percorso mistico, Shiel vi trovò immediatamente lo specchio della sua propria concezione della magia come “anti-scienza” in senso provocatorio, anti-progressista e soprattutto anti-britannico, rimanendo probabilmente impressionato dalla sontuosità e dal barocchismo dei rituali di magia cerimoniale esibiti da S.L. MacGregor Mathers.
In questo si rivelò adepto speculare al francese Joséphin Péladan, che iniziato anch’esso alla Massoneria dal più sobrio Stanislas de Guaita, ne adotterà in pieno l’aspetto più ritualmente appariscente, fondando un “salotto esoterico” e facendosi chiamare “Sar” (“principe” in lingua persiana) Péladan. La magia per Shiel si presenta come l’aspetto più oscuro e “lunare” del Mondo, legata ai misteri del sesso e alla dicotomia tanto in auge durante il decadentismo, di “Eros kai Thanatos”, avvicinandosi in questo a quell’altro decadentista impenitente che fu il giovane Aleister Crowley.
 La sua raccolta di racconti gotici più conosciuta, Shapes in the Fire (ristampata come Xelucha and Others dall’editrice statunitense Arkham House, con l’inserimento aggiuntivo di alcuni racconti tratti da altre antologie) costituisce, fondamentalmente, una riproposizione di temi tipici della narrativa di Edgar Allan Poe arricchiti da spunti esoterici, commistione che rivela un’indubbia originalità di fondo.
La sua raccolta di racconti gotici più conosciuta, Shapes in the Fire (ristampata come Xelucha and Others dall’editrice statunitense Arkham House, con l’inserimento aggiuntivo di alcuni racconti tratti da altre antologie) costituisce, fondamentalmente, una riproposizione di temi tipici della narrativa di Edgar Allan Poe arricchiti da spunti esoterici, commistione che rivela un’indubbia originalità di fondo.“Xelucha” è un racconto tutto incentrato sulla figura dell’“Eterno Femminino” inteso in chiave ambigua e mortifera in puro stile decadentista, e si può leggere come una variazione sul tema delle “morte affascinanti” di Poe; Eleonora, Ligeia e Morella, ma con in più una forte componente “messianica” che non trova eguali nella tematica decadentista del tempo, ma che troverà uno stuolo di imitatori in quella successiva.
Xelucha è una donna “totale”, una manifestazione del Divino inteso nella sua veste più feroce e “dionisiaca”. La sua presenza trasforma le strade della filistea Londra (tema preferito di Shiel, che successivamente la chiamerà direttamente “città di birrai”) in un “baccanale di luci”. Le metafore si susseguono vertiginosamente: Xelucha viene paragonata a una stella (quella di Betlemme? Siamo di fronte a una Natività in chiave femminile?), una iniziatrice di misteri, una sacerdotessa, addirittura una Dea. Assume anche tratti vampirici che la avvicinano alla Helen Vaughan del macheniano “The Great God Pan”, dal momento che anima di una vita oscura e parassitaria un amico del narratore ridotto, dopo la partenza di Xelucha “in Oriente”, a nient’altro che “una larva priva di vita”.
Xelucha decide di partire, appunto, “per dominare l’Oriente” (ossessione onnipresente di Shiel che mai mancherà di rimarcare la sua estraneità al tipo dell’inglese medio, ribadendo fino alla nausea le sue origini indiane), ma laggiù è preda di una malattia che la consuma, anche se “voci” dicono “che Ella non è morta”. Oppresso da una debolezza tutta dandy, una sera il narratore si ritrova a meditare stancamente su di una terrazza e viene avvicinato da una donna di bassa statura, di grande bellezza e fascino. Shiel insiste sul suo seno prosperoso non solo mosso da una spiccata sensualità, che pure egli propugnava candidamente, quanto per ricalcare la mano sugli attributi numinosi della prosperità che è propria delle Dee antiche.
La donna riconosce in lui “un Compagno” e lo guida con sé attraverso una Londra oscura e diafana. I due giungono infine in una casa “arredata secondo il gusto orientale più sfrenato”, vi si avvicendano lampade di diaspro e incensieri accesi, tovaglie di velluto e treppiedi; vi fa da contrasto solo una semplice bottiglia contenente “vino nero”, forse il “Vinum Sabbati” della conoscenza dionisiaca che riduce uno dei protagonisti di Machen a un’orribile larva pre-adamitica. Colà, la strana donna intavola una discussione con il protagonista, mettendone alla berlina le convinzioni borghesi, il “senso comune” anti-iniziatico del quale Shiel si professerà sempre nemico con attitudini gigionesche tipiche della temperie culturale della quale si sentiva figlio, ed erede a tutti gli effetti.
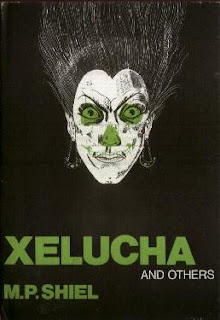 La donna parla del culto del fuoco dei sabei (una popolazione minoritaria dell’Iraq del nord, considerata discendente degli antichi babilonesi e tutt’ora esistente), il fuoco della “Ekpyrosis”, la grande conflagrazione apocalittica professata dagli stoici nel tardo impero romano, influenzati da dottrine orientali. Il senso comune che la donna mette alla berlina è la cecità di un mondo debole, incapace di abbracciare la morte, la larva in decomposizione che cela in sé la fiamma dell’Apocatastasi finale, l’incendio dell’Universo che “immetterà vino nuovo in botti vecchie”. I suoi discorsi insistono su immagini macabre: un consesso di morti in una tomba norvegese, le teste delle mummie poggiate sulle ginocchia consumate, il suono dei denti che attraversano la carne ammuffita per ticchettare sui pavimenti di pietra come perle cadute.
La donna parla del culto del fuoco dei sabei (una popolazione minoritaria dell’Iraq del nord, considerata discendente degli antichi babilonesi e tutt’ora esistente), il fuoco della “Ekpyrosis”, la grande conflagrazione apocalittica professata dagli stoici nel tardo impero romano, influenzati da dottrine orientali. Il senso comune che la donna mette alla berlina è la cecità di un mondo debole, incapace di abbracciare la morte, la larva in decomposizione che cela in sé la fiamma dell’Apocatastasi finale, l’incendio dell’Universo che “immetterà vino nuovo in botti vecchie”. I suoi discorsi insistono su immagini macabre: un consesso di morti in una tomba norvegese, le teste delle mummie poggiate sulle ginocchia consumate, il suono dei denti che attraversano la carne ammuffita per ticchettare sui pavimenti di pietra come perle cadute.Il protagonista prova a scacciare tali fantasie macabre dalla testa di quella che crede solo una sua eccentrica, prossima conquista, invitandola a libare con lui all’amore, ma la donna lo schernisce, forse con lo scherno dell’Iniziato superiore che “porta in sé l’ebbrezza” e non ha bisogno, dunque di stimoli interni. Infine, sconfitto, il narratore cede e in un momento di spossatezza crede di riconoscere in lei la scomparsa Xelucha, per esserne di nuovo schernito: “Pazzo, Ella è morta, il colera la prese. Il morbo consumò la carne della sua guancia fino ai denti”. La Donna parla di una vita oltre la morte, parla di una corruzione universale che, una volta giunta al suo parossismo, trasformerà il mondo, ma il protagonista cede e cade svenuto. Al suo risveglio si ritroverà in un sudicio appartamento, vuoto e polveroso. Unico resto della sua folle notte, una bottiglia di vino per metà vuota.
Per tutto il racconto, peraltro breve, si respira un’aria di abbandono e malattia e al tempo stesso, per contrasto, un’atmosfera di vibrante eccitazione suggerita da immagini di potente sensualità. In “Xelucha” si rimane catturati da una terribile ambiguità che nasconde il messianismo nella follia e viceversa. Come non pensare dunque al “Riparatore di reputazioni” di R. W. Chambers di cui questo racconto è chiaramente ispiratore? In Chambers viene rappresentata la stessa aria messianica, c’è tutta la follia del fanatismo apocalittico incarnata nella figura dell’“Imperatore d’America”. In “The Yellow Sign”, inoltre, rimane immutata tutta l’insistenza su fantasie di morte di “Xelucha” (Il custode del cimitero “che somiglia a un grasso verme”, etc.) mentre l’attesa di una Rivelazione apocalittica rimane sempre in agguato, stavolta sotto forma di un terribile libro.
Insomma, non ci vuole una grande immaginazione per riconoscere che fra le scollature ubertose di Xelucha fanno già capolino gli stracci polverosi de “Il Re in Giallo”, anche loro annunciatori di una prossima Apocalisse. H.P. Lovecraft parlerà più in là di un “Mago”, Nyarlatothep, anch’egli proveniente dall’Oriente, anch’egli un facitore di miracoli (la morte verrà con lui), mentre Clark Ashton Smith rappresenterà tutta una serie di terribili incantatrici e vampire da “Morthylla” a “L’Incantatrice di Sylaire”, tutte caratterizzate da una carnagione “vicina al pallore della morte” (Xelucha è prosperosa ma “circonfusa da una luce bianca e diafana”) e manifestantesi tutte in prossimità di una catastrofe imminente.
 In pratica, questo racconto di Shiel è la dimostrazione più lampante del fatto che considerare la sua produzione “gotica” come meramente tributaria di Poe, operazione che David Punter implicitamente suggerisce, è ipotesi riduttiva e quanto meno azzardata. In Edgar Allan Poe, “abbracciare la morte” non supera il livello della fantasia macabra (sicuramente suggerita dalla morte prematura della sua adorata Virginia), mentre in Shiel assume proporzioni cosmiche, un buon preludio ai fasti de La nube purpurea.
In pratica, questo racconto di Shiel è la dimostrazione più lampante del fatto che considerare la sua produzione “gotica” come meramente tributaria di Poe, operazione che David Punter implicitamente suggerisce, è ipotesi riduttiva e quanto meno azzardata. In Edgar Allan Poe, “abbracciare la morte” non supera il livello della fantasia macabra (sicuramente suggerita dalla morte prematura della sua adorata Virginia), mentre in Shiel assume proporzioni cosmiche, un buon preludio ai fasti de La nube purpurea.“The House of Sounds” (osannato da Lovecraft) è una originale variazione su “La caduta della casa degli Usher” di Poe. Qui, la prima cosa che si nota è una sorta di cameratismo che intercorre fra i due protagonisti, elemento che in Poe sussiste solo in potenza mentre il resto della narrazione è un vero e proprio prodigio stilistico. Il rumore onnipresente della cateratta è un geniale escamotage di Shiel, in un ambiente dove l’udito è cancellato la comunicazione si fa impossibile; dovrà dunque per forza essere di tipo visivo, e qui la prosa di Shiel, che definire “scoppiettante” è dire poco, è al suo meglio.
La casa è letteralmente “assediata” dal ruggito della cateratta, simbolo della Realtà, giornalmente erosa dall’attacco della follia come la mente dei protagonisti. Per reazione, la casa squaderna la propria risposta spaziale a ciò che spazio non possiede, né dimensioni: il suono. I piani si avvicendano ai piani, le stanze alle stanze, le superfici di vetro alle superfici, nel patetico tentativo di riflettere qualcosa di diverso dalla propria bruciante ossessione. La reiterazione delle parole “rumore” e “frastuono” è talmente ossessiva che il lettore non potrà evitare di cominciare a sentire la lontana eco di un boato… e l’invitabile finale non si farà attendere.
In “L’oscuro destino di un certo Saul” Shiel si cimenta invece con “l’assenza” di luce, non perdendo ugualmente nulla in vivacità. Un naufrago viene gettato in mare, chiuso in una botte, per approdare in una caverna sottomarina dove regnano le tenebre, variazione stavolta sul Gordon Pym dello scrittore di Boston. All’inizio il naufrago lamenta la sua condizione meschina, ma un pensiero religioso illumina il racconto di una luce oscura: “Se salgo sù, in Paradiso, Lui (leggi: Dio) è lì; se faccio il mio letto nell’Inferno, Lui è là; se prendo il volo di mattina e mi fermo nella zona più lontana dell’Oceano anche lì troverò la Sua mano che guiderà il mio cammino. Anche lì la Sua mano destra mi sosterrà”.
Questo diventa la stura ironica e crudele di Shiel per “mettere alla prova” il suo protagonista. Il signor Saul trova la maniera di fare luce usando dei papiri, ma il suo è un mondo immerso nelle tenebre, laghi sotterranei enormi si spalancano nell’abisso, isole solitarie e tunnel. L’ironia antisociale di Shiel si scatena anche qui: il protagonista trova delle radici di mescalina e comincia ad assumerle quotidianamente (la droga, come pure il sesso, sono elementi chiave nella narrativa di Shiel). L’uso della pianta psicotropa, unita alla percezione costante di un mondo oscuro, apre nella mente del protagonista una “visione notturna” da intendersi forse in senso iniziatico, contrapposta a quella “diurna” della sua vita passata in superficie. Il suo Dio diviene un Dio sotterraneo e Ctonio, il suo avatar, una Creatura Mostruosa che vive nelle acque, dalla forma vagamente antropomorfa, gli occhi ciechi, la bocca aperta in un urlo immane e silenzioso (forse un antenato del “Dagon” di Lovecraft?), visione inquietante e spaventosa forse indotta dall’uso della droga e dalle riflessioni religiose del signor Saul. O forse no?
[Continua]
Mariano D’Anza

Nessun commento :
Posta un commento
Lascia un tuo commento.