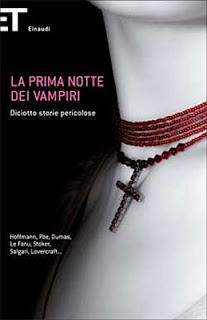Saggio in tre parti. 
Il lupo mannaro è, in buona compagnia con il vampiro, una delle figure più classiche del nostro immaginario collettivo. I miti e le leggende di ogni tempo e paese sono piene di storie di uomini che si trasformano in bestie, codificate per la prima volta, in vera e propria casistica metamorfica, da due eccentrici studiosi del folklore europeo come
Sabine Baring-Gould (in
The Book of the Were-Wolves, 1865) e dal Reverendo
Montague Summers (
The Werewolf, 1933). Al di là delle asettiche classificazioni dei miti e delle fole popolari, è però in campo letterario che l’archetipo del licantropo ha trovato nuova linfa per far prosperare la sua leggenda. Già nelle
Metamorfosi di
Ovidio (43 a.C.) troviamo la storia di Licaone mutato in lupo da Zeus. Nella letteratura classica ci sono poi gli antecedenti del
Satyricon di
Petronio (60 d.C.), dove si raccontava la storia di un “versipellis” – così i romani chiamavano il lupo mannaro – come riferita da Nicerota al banchetto di nozze di Trimalcione, e i numerosi testi zooantropici del periodo medievale.
Le prime apparizioni licantropiche dei tempi moderni si trovano nel romanzo di
Frederick Marryat The Phantom Ship, scritto nel 1839 (una lunga rielaborazione della leggenda dell’Olandese Volante in cui è incluso il capitolo
The Werewolf of the Hartz Mountains, su una ragazza-lupo), in
Wagner the Wehr-Wolf (opera-fiume che
George William Reynolds, influenzato dall’interesse allora dilagante per l’occulto, pubblicò in ben settantasette fascicoli tra il 1846 e il 1847), e in
Le Meneur des Loups del francese
Alexandre Dumas, del 1860 (non proprio sui lupi mannari ma su un “conduttore dei lupi”, uno stregone che ha potere su questi animali). Un notevole testo gotico che, purtroppo, risulta ancora inedito in italiano, è poi
The Albigenses di
Robert Charles Maturin (1824), in cui un licantropo si muove nelle segrete di un antico castello; anche se qui il lupesco protagonista appare in un solo episodio, come storia a parte incastonata nella narrazione principale.
Secondo il critico
Andrew Barger, compilatore di
The Best Werewolf Short Stories 1800-1849: A Classic Werewolf Anthology (Bottletre Books, 2010), la prima donna-lupo della letteratura, se non si conta la comparsata in
The Phantom Ship, prende forma nel romanzo
Sidonia the Sorceress dello scrittore tedesco
Johannes Wilhelm Meinhold, uscito in due volumi nel 1849 e tradotto in inglese da Lady Wilde, madre del più famoso Oscar. La Sidonia del titolo viene descritta come un “idolo di perversità”, tuttavia la sua natura bestiale e predatoria è ancora troppo legata alla figura della
femme fatale del romanticismo tedesco.
Due sono le classiche
werewolf stories britanniche dell’ultima decade dell’Ottocento: “The Werewolves” (1898) di
H. Beaugrand, e “Loup Garou!” (1899) di
Eden Phillpotts. La prima, più suggestiva, trova ambientazione tra le foreste del Canada, dove un trapper racconta del suo singolare incontro con una tribù di indiani intenti a danzare attorno al fuoco... Umani in tutto, ma con la coda e testa di lupo! E tra le prime storie brevi a uscire in Inghilterra, si ricordano ancora “Father Meuron’s Tale” (1907) di
R.H. Benson, nel quale una giovane contadina che esibisce i simboli della licantropia viene curata con un esorcismo, e “The Undying Thing” (1901) di
Barry Pain, dove la maledizione licantropica affligge una strana famiglia di aristocratici.
Queste prime storie, insieme ad altre che cominciavano ad apparire sui
dime-novels, le riviste popolari del tempo, portarono in auge nella
fiction le creature mannare grazie anche allo stimolo offerto dai movimenti culturali del periodo, come il Romanticismo e il Decadentismo. È soprattutto nella letteratura inglese, col suo retroterra di atavismo e leggende, che la figura del licantropo trova terreno fertile, e anche scrittori del calibro di
Agatha Christie (con
The Hound of Death, 1933)
Arthur Conan Doyle (
The Hound of the Baskervilles, 1901-02) e
Robert Louis Stevenson (
Olalla, 1885) hanno scritto memorabili variazioni sul tema.

Il primo romanzo di cui è protagonista un licantropo a essere pubblicato in Inghilterra, comunque, è il già citato
Wagner the Werewolf (questo il titolo dato alle più recenti edizioni) di George W.M. Reynolds, un dimenticato maestro del
penny dreadful – come venivano chiamate le prime opere popolari del terrore – oggi dimenticato ma al tempo famosissimo. Più storia d’avventura che horror di stampo gotico, narra la storia di tal Fernand Wagner, un vecchio e solitario misantropo che, durante una notte di tempesta, viene visitato dal Dr. Faust. La mefistofelica apparizione gli offre la possibilità di tornare giovane e in salute, ma in cambio Wagner dovrà accettare di trasformarsi in licantropo durante le notti di luna piena. Egli naturalmente accetta. Il resto della storia vede quindi i tentativi di Wagner per trovare una cura alla sua condizione di uomo-lupo, e tra audaci briganti, eroine in pericolo e sadiche religiose, il protagonista trova anche il tempo di coronare una sua storia d’amore con la bella ma fatale Nisida. Ambientato per gran parte nella Firenze del medioevo, il lungo romanzo è narrato in tono melodrammatico ed è pieno di tanti, forse troppi personaggi secondari che rendono difficile da seguire la vicenda principale. Anche il diavolo stesso fa una sua comparsata, almeno in un paio d’occasioni...

Brughiere brumose, boschi infestati e locande solitarie, gli elementi tipici della tradizione fantastica anglosassone nonché luoghi prediletti per le creature della luna piena, si trapiantano dunque nella prima narrativa fantastica e diventano presto un “topos” del genere. Tra le opere più significative emerse in terra d’Albione, la migliore è forse
The Door of the Unreal di
Gerald Biss (1876-1922), romanzo pubblicato a Londra nel 1919 e considerato oggi un vero classico della letteratura soprannaturale.
H.P. Lovecraft stesso lo elogiò in
Supernatural Horror in Literature, e a riguardo scrisse che il romanzo
“… tratta in modo piuttosto abile lo scontato tema della licantropia”. Secondo alcuni critici, è stato l’opera che ha poi spianato la strada che ha portato all’Età d’Oro del filone licantropico. La trama s’incentra su misteriose sparizioni di persone che funestano la contea del Sussex, un caso che la polizia locale sembra incapace di risolvere. I due protagonisti della storia, fratello e sorella, si trovano invischiati nelle indagini e scoprono che dietro tutte le sparizioni c’è la sinistra figura del dott. Wolff (nomen omen!), un botanico tedesco che si rivelerà essere un lupo mannaro. Alla morte di questi, sarà la figlia a perpetrarne la lunga scia di sangue.
Tra le opere classiche tradotte anche da noi, ricordiamo invece
The Were-Wolf di
Clemence Annie Housman (Tr. it.: “Pelliccia Bianca”, in
Le Signore dell’Orrore, Longanesi, 1973), novella scritta nel 1896 che
Sam Moscowitz, esperto e storico di letteratura
pulp, ha definito
“la più singolare opera di narrativa mai scritta sul tema della licantropia”. Vi si narra la storia di due fratelli, i quali entrano in conflitto a causa di una misteriosa ragazza che,dietro una bellezza ferina cela la sua natura ambigua di donna-lupo.

Tra i primi romanzi inglesi a trattare in modo compiuto il tema della licantropia, c’è anche
The Undying Monster. A Tale of the Fifth Dimension, romanzo scritto nel 1922 da
Jessie Dougles Kerruish (Tr. it.:
Il mostro immortale, I Romanzi di Urania n. 85, Mondadori, 1955). In quest’opera una maledizione atavica colpisce gli eredi di un’antica casata, che vengono perseguitati da un mostro licantropico e apparentemente immortale che miete le sue vittime nelle notti di luna piena. La storia è sovrabbondante di sinistre atmosfere, ma risente ancora troppo del sorpassato filone del gotico.
La figura del lupo mannaro dovrà trasferirsi al di là dell’Oceano, per l’esattezza in America, per rivitalizzarsi e uscire dai suoi clichè di nebbie e di foreste. Il Nuovo Mondo non possedeva ancora una propria tradizione di leggende su cui basarsi, al contrario dell’Europa ricca di storia, e si ingegnò nell’inventarsi un sostegno mitologico che reinterpretasse con autonoma originalità i vecchi miti anglosassoni. Su questa base gli americani hanno costruito, e in taluni casi reinventato, un passato pseudostorico e di leggenda divenuto familiare anche per noi.
Come fonte d’invenzione fantastica, anche la figura del licantropo venne ripresa dal Vecchio Continente e incorporata in uno scenario nuovo ma sicuramente originale e carico di fermento. Attecchì soprattutto nelle riviste popolari degli anni Trenta, i cosiddetti
pulp magazines, e in modo particolare sulla decana di esse,
Weird Tales, che del bizzarro e dell’immaginazione si era fatta portavoce durante gli anni della Grande Depressione, offrendo al popolo americano un motivo d’evasione dal grigiore della vita di tutti i giorni. Qui agiva un manipolo di scrittori che, capitanati da un maestro come Lovecraft, riuscirono a dare un nuovo volto al racconto fantastico di stampo ottocentesco, diventato obsoleto con l’avvento della civiltà industriale, determinando di fatto una rottura con il gotico tradizionale e creando una nuova mitologia alternativa che prendeva le mosse da un reale
“dilaniato dagli orrori della prima guerra mondiale, e scosso dal fermento che le nuove tecniche scientifiche, prima quelle di Albert Einstein, hanno provocato”. (Cfr. Giorgio Giorgi, “La ‘scuola di Weird Tales’ come necessità di una nuova mitologia”, in
Percorsi nel Fantastico, Il Cerchio Iniziative Editoriali, 1997).
Questo “rovesciamento” della tradizione fu avvertito in modo particolare da alcuni scrittori del fantastico più attenti alle trasformazioni in atto, i quali videro crollarsi addosso tutto l’impianto retorico tradizionale che fino ad allora aveva fornito la base alle loro opere. Prendendo coscienza di questa nuova visione del mondo “allargata”, che offriva motivo a nuove e più grandi irrequietezze e paure, fecero sparire dalla loro narrativa tutti gli orpelli gotici ormai stantii e odorosi di muffa, le cripre, i castelli, i cimiteri nebbiosi e le foreste stregate, e posero le basi per l’avvento di un
new horror di stampo moderno e non più antropocentrico.

In questo scenario la figura del lupo mannaro non era comunque destinata a sparire. Si trasforma invece sulla base di questa nuova dimensione dell’Ignoto, e continua a prosperare; merito anche del successo ottenuto da alcuni studi antropologici sul folklore occidentale, come quello di Summers, citato all’inizio, in cui gli autori di
pulp-magazines trovarono ispirazione per scrivere proprie storie licantropiche.
Howard Phillips Lovecraft (1890-1937) fu il principale rinnovatore degli elementi del gotico e uno dei primi a rispolverare il tema del
werewolf nel racconto “The Hound”, che pubblicato nel febbraio 1924 su
Weird Tales, si tinge di una inedita visione “cosmica” che non lascia spazio alla superstizione. Resosi conto che le tradizionali storie di vampiri, licantropi e spettri avevano fatto il loro tempo, ed erano ormai fuori moda alla luce delle moderne teorie della scienza, che aprivano ora a terrori più grandi, Lovecraft ridisegnò la mappa del fantastico e delle sue principali icone; unendo l’orrore con la fantascienza rese più attuale la vecchia concezione del vampiro in “The Shunned House”, della strega in “The Dreams in the Witch House” e, appunto, del licantropo, che nella sua opera appare anche nel sonetto “The Howler” facente parte della raccolta di poesie
Fungi from Yuggoth. E di Lovecraft ricordiamo anche il lungo poema “Psychopompos” (
Weird Tales, settembre 1937), che vede un malvagio barone medievale terrorizzare i suoi vassalli in forma di grosso lupo.

Gli altri due “Moschettieri” di
Weird Tales,
Robert Ervin Howard (1906-1936) e
Clark Ashton Smith (1903-1961), non furono da meno nel riplasmare alla loro maniera la figura del
wolfman letterario. Howard lo fece in una accezione più classica, ma non priva di originalità e genuino vigore narrativo. In “The Forest of Villefere” (
Weird Tales, agosto 1925) lo spadaccino de Montour incontra un temibile licantropo sui pericolosi sentieri della Francia del XVII secolo. La sua lama avrà la meglio, ma in un racconto seguente, “Wolfshead” (
Weird Tales, aprile 1926), apprendiamo che a seguito di quell’avventura de Montour, per uno strano scherzo del destino, era rimasto lui stesso vittima della maledizione licantropica, destinato ad assumere mostruose sembianze lupesche nelle notti di luna piena. Lo scenario, questa volta, è la costa occidentale dell’Africa dove un nobile possidente spagnolo, Dom Vincente da Lusto, ha costruito un solitario castello. “Black Hound of Death” (
Weird Tales, novembre 1936) si svolge invece nelle oscure foreste di pini del Sud degli Stati Uniti, e Howard vi narra l’allucinante vicenda di Adam Grimm, trasformato in creatura bestiale, mezzo uomo e mezzo lupo, dalle Nere Arti dei Sacerdoti di Erlik. Senza dimenticare Atla, la donna-lupo che nel racconto “Worms of the Earth” (
Weird Tales, novembre 1932) aiuta Bran Mac Morn a compiere il suo spaventoso viaggio negli inferi della Terra.
Dal canto suo Clark Ashton Smith, scrittore abilissimo nel campo della
science fantasy, offre un’altra diversificazione della licantropia in “The Beast of Averoigne” (
Weird Tales, maggio 1933), che prende spunto da una vecchia leggenda provenzale, quella della Bestia del Gevaudan (l’enorme lupo che terrorizzò i boschi di Francia nel XVIII secolo) reinterpretata però nell’ottica dei lovecraftiani “Miti di Cthulhu”. Per Smith il lupo mannaro è una figura-simbolo preferita per esprimere le paure che si annidano nei boschi, e benchè tali creature appaiano direttamente soltanto in due sue storie della serie di Averoigne (oltre a quella citata anche in “The Enchantress of Sylaire”, dove s’incontra il personaggio di Malachia du Marais, un uomo trasformato in licantropo dagli incantesimi di una maga) esse sono “onnipresenti” dietro le quinte di ognuna. Più tardi questo scrittore affronterà ancora il tema, ma volgendolo in chiave decisamente satirica, nel bizzarro racconto “Monsters in the Night” (
The Magazine of Fantasy & Science Fiction, ottobre 1954). Qui troviamo un licantropo che assale per errore un robot scambiandolo per un uomo!

Altro famoso contributore di
Weird Tales fu
Henry St. Clair Whitehead (1882-1932), anche lui amico di Lovecraft e autore tra i più interessanti del primo dopoguerra americano. Pur essendo un diacono della Chiesa episcopale nelle Isole Vergini, Whitehead era accompagnato da una eccezionale fama di uomo forte e coraggioso, che oltre ad essere un intrepido cacciatore di serpenti era anche uno studioso di oscuro folklore. E per spavalderia nei confronti delle superstizioni di quei luoghi, si vantava di avere per amici due veri lupi mannari! Nel suo racconto “No Eye Witness” (
Weird Tales, agosto 1932) uno scienziato prova un macchinario avveniristico, una specie di video capace di mostrare scene accadute in passato, e assiste da testimone involontario alla nascita della leggenda sui licantropi. In questa storia è particolarmente originale la fusione di fantascienza, orrore e mito. Un altro esempio di storia licantropica lo troviamo poi in quello che è forse il suo racconto più famoso, “Jumbee” (
Weird Tales, settembre 1926), che prende spunto dal folklore caraibico. Qui, per magia voodoo, una vecchia strega si trasforma in un pericoloso cane il cui tocco significa la morte. Whitehead si riferisce al fenomeno definendolo come “canicantropia”.
[
Continua]
 Quello del "cacciatore di vampiri" è un tema vasto, forse appena un filo — filo di sangue, s’intende — meno vasto dell’argomento stesso del loro oggetto di preda. Dacché esistono vampiri, che appartengano al mito o alla superstizione sino alla finzione narrativa, è necessaria e quasi inevitabile la presenza di una nemesi, un avversario non sempre o necessariamente del tutto umano, una figura di sapiente in grado di individuarli, un antagonista di particolare abilità nel combatterli.
Quello del "cacciatore di vampiri" è un tema vasto, forse appena un filo — filo di sangue, s’intende — meno vasto dell’argomento stesso del loro oggetto di preda. Dacché esistono vampiri, che appartengano al mito o alla superstizione sino alla finzione narrativa, è necessaria e quasi inevitabile la presenza di una nemesi, un avversario non sempre o necessariamente del tutto umano, una figura di sapiente in grado di individuarli, un antagonista di particolare abilità nel combatterli. Ed è in questo panorama che emerge la figura del dhampyr, a cui si rifanno sia il quasi omonimo Dampyr dei fumetti Bonelli che lo stesso personaggio di Blade, dagli inchiostri alla trasposizione in celluloide.
Ed è in questo panorama che emerge la figura del dhampyr, a cui si rifanno sia il quasi omonimo Dampyr dei fumetti Bonelli che lo stesso personaggio di Blade, dagli inchiostri alla trasposizione in celluloide. E con la narrativa popolare del Novecento, anche personaggi seriali minori s’improvvisano talvolta esperti in materia di nosferatu e affini, come il pur non eccelso Jules de Grandin, tipico “investigatore dell’occulto” creato da Seabury Quinn nel 1925 sulle pagine di Weird Tales.
E con la narrativa popolare del Novecento, anche personaggi seriali minori s’improvvisano talvolta esperti in materia di nosferatu e affini, come il pur non eccelso Jules de Grandin, tipico “investigatore dell’occulto” creato da Seabury Quinn nel 1925 sulle pagine di Weird Tales. Dal cinema della britannica Hammer, che vede il grande Peter Cushing incarnare il tipo dello spietato distruttore di non morti (sia nella serie dei Dracula che nel ciclo ispirato a Le Fanu), proviene anche il curioso personaggio di Capitan Kronos, settecentesco cacciatore di vampiri in stile “cappa & spada” protagonista del (purtroppo) inedito in Italia Captain Kronos Vampire Hunter (1974).
Dal cinema della britannica Hammer, che vede il grande Peter Cushing incarnare il tipo dello spietato distruttore di non morti (sia nella serie dei Dracula che nel ciclo ispirato a Le Fanu), proviene anche il curioso personaggio di Capitan Kronos, settecentesco cacciatore di vampiri in stile “cappa & spada” protagonista del (purtroppo) inedito in Italia Captain Kronos Vampire Hunter (1974). Troppi nomi ed esempi indubbiamente mancano a questa che è solo una fuggevole occhiata sul tema della "caccia al vampiro". A partire dallo spaccone Jack Crow del film Vampires (1998) di John Carpenter, tratto a sua volta dal romanzo Vampiri S.p.A. (Vampire$, 1990) di John Steakley. Non ce ne vogliano i diretti interessati... serbando i loro aguzzi paletti di frassino per meno vive e assai più degne carcasse.
Troppi nomi ed esempi indubbiamente mancano a questa che è solo una fuggevole occhiata sul tema della "caccia al vampiro". A partire dallo spaccone Jack Crow del film Vampires (1998) di John Carpenter, tratto a sua volta dal romanzo Vampiri S.p.A. (Vampire$, 1990) di John Steakley. Non ce ne vogliano i diretti interessati... serbando i loro aguzzi paletti di frassino per meno vive e assai più degne carcasse.